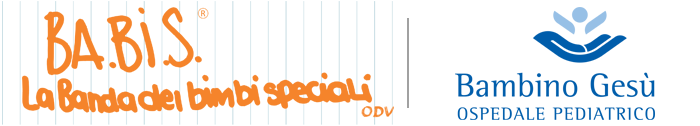LO SPAZIO BIANCO
Trama:
«Il fatto è che mia figlia Irene stava morendo, o stava nascendo, non ho capito bene…»
“Io leggevo”: Maria ha superato la soglia dei quaranta, insegna italiano in una scuola territoriale serale, è sola. A causa di complicazioni non specificate – “a quarant’anni non si fanno i figli” – nasce Irene, a soli sei mesi di gestazione. E Maria, incrollabile nelle sue certezze elaborate in anni di formazione dura, periferica, anni da scuola di partito stretti da un padre rigorosamente comunista e da un madre cattolica, oppone al dolore, la sua strategia consueta. Leggere, ovvero isolarsi impedire al mondo esterno di sfondare il proprio nocciolo d’identità, chiamare a sé le forze della ragione, rifugiarsi, come Montaigne, nel regno pacificato dei propri studi. Un saggio sul laicismo, non a caso, perché “non sento curiosità nel dubbio, né fascino nella speranza”. Ma per quanto Maria sia strutturata, Irene è la buca nella quale inciampa, un essere che non è figlia maturata, “una forma senza immagine, un atto vivente che dietro di sé non aveva nessuna idea platonica a sorreggerlo” che non può, per sua intrinseca essenza, conferirle lo statuto di madre.
Nonostante, dunque, la totale mancanza di categorie di pensiero attraverso le quali sistemare la nascita di Irene, Maria è costretta a imparare un nuovo alfabeto, a ricominciare, in qualche modo, da zero. Da quella incubatrice bianca / scatola bianca / spazio bianco che, suo malgrado, trasmette un irresistibile seduzione, sia essa verso la vita o verso la morte.
Il romanzo di Valeria Parrella è la cronaca dello spazio e del tempo in cui Irene, e sua madre, artificialmente arrivano al punto di partenza di una nascita “naturale”. Con loro, i medici, le infermiere, le altre madri, i padri, gli amici rimasti, i colleghi, gli allievi, e i ricordi. Intorno a loro, oltre all’ospedale (ai suoi cornicioni, alle anticamere, alle sale d’attesa, al reparto neonatale per prematuri con tutte le sue, a tratti quasi macabre, contraddizioni), la casa di Maria ben protetta da un portone antipanico, l’aula di scuola, e alcune, poche, vie di Napoli dove la protagonista s’immerge come bendata, in quella sorta di alternanza tra sonno e veglia che sono i giorni della cosiddetta rinascita di Irene. Che arriva, in effetti: prima con l’autonomia respiratoria poi con l’allattamento con il biberon (davvero efficaci le pagine che descrivono i primi approcci di Maria con il biberon e le difficoltà della bambina a ingerire il latte, con quel continuo chiedersi il perché un atto naturale possa trasformarsi in un motivo di preoccupazione, d’angoscia o anche di perdita definitiva) e infine con la dimissione di Irene.