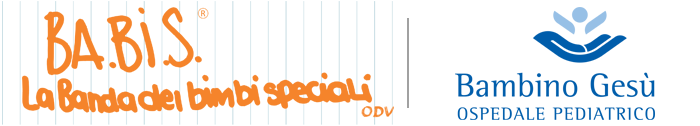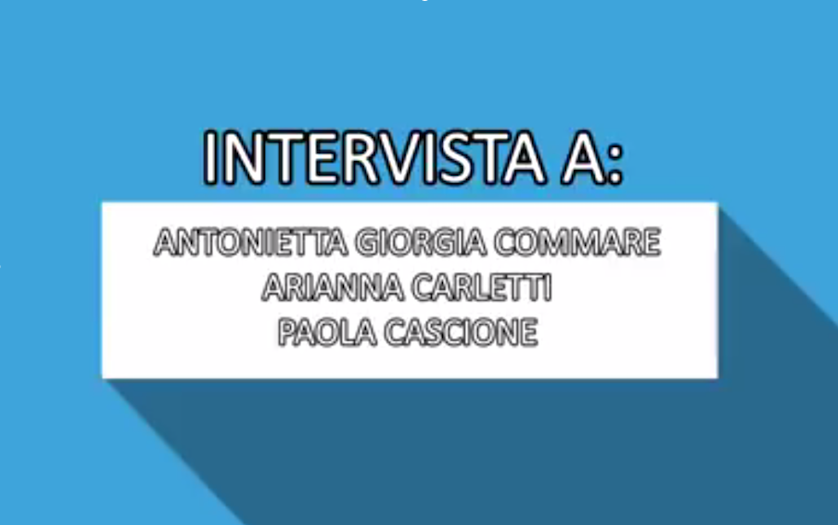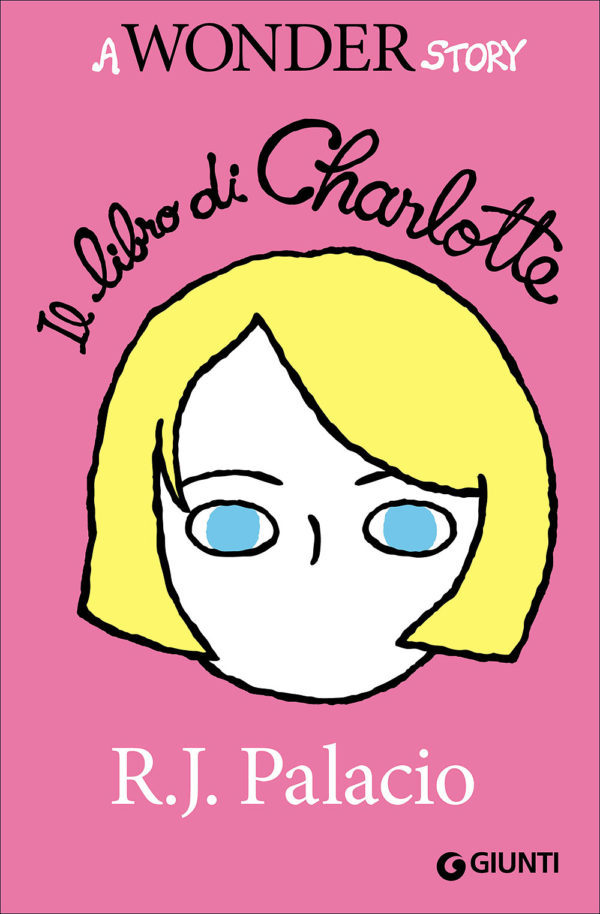QUANDO IL MONDO REGALA UN FIGLIO SPECIALE (Labiopalatoschisi)
Un figlio è sempre un regalo che la vita ti fa, ma a volte per qualche regalo ci si mette a complottare l’Universo intero.
La mia esperienza di mamma di un bimbo speciale, bimbo nato con una severa malformazione cranio-facciale, ha una peculiarità: è l’esperienza di una mamma non biologica, bensì adottiva. Faccio parte di quei genitori che sono arrivati alla consapevolezza della patologia del proprio figlio dopo un percorso di presa di coscienza, dopo una scelta. Un genitore adottivo si misura con i concetti di disabilità, malformazione, patologia, quando il figlio è ancora un’idea. Ovviamente la natura porta tutti a desiderare un figlio sano, con 5 dita su ogni manina, 5 dita su ogni piedino, ogni cosa a suo posto, ben formata, ma poi mano a mano che si procede nel percorso adottivo, e durante gli incontri di approfondimento con gli psicologi e gli assistenti sociali, si matura la consapevolezza della realtà e si fissano i propri limiti di accoglienza (e comunque sì, pure io in un gesto istintivo e primordiale la prima cosa che feci quando mi misero in braccio i miei figli era contare le dita di mani e piedi).
Facciamo un salto indietro: sulla nostra relazione era scritto: La coppia si dichiara disponibile ad accogliere bambini con handicap lievi e/o reversibili. La labiopalatoschisi non è certo lieve, ma reversibile sì. Quindi Joshua rientrava in pieno nella nostra disponibilità. Malgrado ciò, il suo arrivo è stato inatteso. Un po’ come succedeva decenni fa, quando la gravidanza gemellare si scopriva solo alla nascita. Così partiamo per la Nigeria, abbinati a un solo bambino, pur avendo i documenti per due. Il figlio che ci attende si chiama Emmanuel, e ha 3 anni. Arrivati in loco, il Ministero che si occupa del dossier delle adozioni internazionali si accorge che la nostra disponibilità è per due e decide di abbinarci un secondo minore. “Accettate un bambino con disabilità?” ci chiedono, senza precisare null’altro. “Rientra nei nostri limiti?” chiediamo.
Più volte prima di arrivare al figlio si ha la possibilità di scegliere. Non essendo genitori biologici si ha la legittimità del rifiuto. E’ lecito, anzi d’obbligo, dichiarare “no, non me la sento!”. E la possibilità di rifiutare un abbinamento, per quanto possa essere pesante, è sicuramente più semplice della decisione di due genitori che si trovano, dopo una morfologica dagli esiti non rosei, a contemplare l’eventualità di un aborto terapeutico.
Ma noi avevamo già accettato l’idea di un figlio con un percorso sanitario tutto da definire e da percorrere, quindi accettammo con grande gioia e serenità. Per una mamma adottiva è più semplice, in queste condizioni, arrivare al figlio con cuore leggero, perché non c’è traccia di sensi di colpa per aver involontariamente influito nell’esito, non ci si sente artefici e o creatrici della sua malformazione. La madre biologica invece sente un peso, una responsabilità enorme. Pesa su di lei il non avere contribuito alla continuazione della specie con la perfezione che la natura esige. Ed è un peso non indifferente, che delle volte porta al distacco, al rifiuto del nascituro, e può determinarne l’abbandono. La madre adottiva sente invece solo la gioia di un grande regalo che il mondo le fa.
Sente la gratitudine perché qualcuno l’ha considerata degna di diventare custode, nutrice, madre di una vita che arriva da di fuori di sé, e non importa se non è perfetta. La madre adottiva sceglie di essere madre di un bambino portatore di disabilità senza conflitti interiori. Una madre biologica dà un figlio al mondo, mentre nel nostro caso il mondo dà un figlio a una madre. Una dà, l’altra riceve.
Ma le difficoltà arrivano per tutti. E così è stato anche per noi.
Durante i primi giorni, anzi il primo giorno, quando ci trovammo a gestire l’allattamento di un piccino messo tra le braccia, senza la capacità di suzione da parte sua, senza esperienza da parte nostra e senza i consigli e il supporto di uno specialista. Per un tempo che allora definirei infinito, barcollavo nello sconforto più assoluto. I primi momenti mi sono intimamente chiesta se avevo fatto il passo più lungo della gamba, accettando un bambino che non riuscivo a nutrire. Le indicazioni delle tate dell’istituto, dal quale Joshua proveniva, erano “quando piange gli date 10 ml di latte, non di più, altrimenti può soffocare dal rigurgito”, si sono rivelate da subito non sufficienti, da sole, a colmare la nostra inesperienza.
Lui non piangeva affatto. Era denutrito e fortemente disidratato.
Ma godeva ora di un nutrimento mai avuto prima: l’abbraccio caldo di una mamma. Il primo giorno sono riuscita con grande fatica a dargli 8 ml di latte. Verso sera il papà prende il biberon e studia il buco. “Io ne faccio altri”, dice. Ma io, memore delle parole delle tate, ho paura di soffocarlo.
Dall’altra parte del mondo, come se qualcuno avesse colto la mia disperazione, una mamma mi viene in soccorso. A sua insaputa, diventa il mio faro in questa navigazione senza bussola in un buio assoluto. Ci chiama la fidanzata di mio fratello, nata 30 anni fa con labiopalatoschisi monolaterale completa, per recapitarmi il messaggio di sua mamma: “Mi ha detto di dirti di non aver paura di nutrirlo. Lui non soffocherà mai. Ad altri bambini può capitare, a lui no. Non gli andrà mai storto”. “Vai, buca la tettarella!” dico allora al papà, che con un ago bruciato fa 7 buchi alla tettarella.
E Joshua comincia a bere.
Nel giro di qualche giorno riesco ad arrivare a 80 ml ogni 2 ore senza perdere neanche una goccia, né dal naso né, tantomeno, dalla bocca. Lui puntuale ogni 2 ore reclama. Mi accorgo che tutto il latte che rigurgita lo tiene rigorosamente in bocca e se lo rimangia piano, piano.
Jo, così lo chiamiamo, mangerà ogni due ore per i successivi 3 anni, e questa sarà la vera fatica, che quasi nulla ha a che fare con la sua patologia.
Il nostro piccolino comincia a fiorire, mangia, dorme, ride, non perde di vista mai papà e fratellino, partecipa ai momenti della famiglia appena formata. Qualche volta mentre lo tengo in braccio mi accorgo di uno strano rantolo, come quello di mio zio cardiopatico nei suoi ultimi giorni di vita. Siamo arrivati in Italia quando Jo aveva 4 mesi. Ancora storditi e disorientati cominciamo finalmente a cercare cos’è questa labiopalatoschisi, come e dove si cura. Arrivati sabato, martedì riusciamo a contattare un genitore di bambino con labiopalatoschisi (LPS) e allora presidente della associazione Labiopalatoschisi Sardegna. Casualmente si tratta di un neonatologo. In mattinata lo portiamo da lui, che ci informa sugli ospedali pediatrici che trattano la labiopalatoshisi e sarà lui il primo a diagnosticare la cardiopatia di Joshua: Difetto interventricolare (DIV) di un centimetro circa. “Il bambino ha un grande buco al cuore” cerca di spiegarci.
Ma il buco al cuore ce l’hanno tutti i bimbi che sono stati abbandonati. Ebbene, faremo in modo che si chiuda pure quello!
Cominciano le analisi nel reparto cardiologia pediatrica dell’Ospedale Brotzu e le analisi per escludere che si tratti di Lps sindromica. Il DIV non compromette lo sviluppo e per fortuna non c’è associazione tra cardiopatia e LPS. Il bimbo cresce velocemente, bruciando tappe e tabelle.
Sia la cardiopatia che la ricerca di un centro di eccellenza per curare la labiopalatoschisi di Jo ci portano ad un grande Ospedale Pediatrico, al Bambino Gesù. Faccio lo svezzamento con palato e labbro aperto, senza problemi, in attesa del fatidico primo intervento. La prima data fu fissata quando aveva 8 mesi, ma saltò, perché arrivammo a Roma dalla Sardegna, dove viviamo, con un principio di bronchite. Slittò di tre mesi e con il senno di poi dico che è stato un bene. Lui si è rasserenato, si è sentito accettato e accolto e non come “bimbo da aggiustare”, prima di diventare figlio.
Abbiamo fatto in tempo a creare quei fragili equilibri di famiglia che ci servivano.
Joshua è stato operato a 11 mesi.
Le ansie e il carico emotivo sono quelli che tutti i genitori che si trovano fuori da una sala operatoria ben conoscono. Nel caso di una famiglia adottiva invece vengono ad aggiungersi ulteriori varianti. L’ospedalizzazione ha un peso non indifferente sui processi della costruzione dei legami di famiglia.
Diventare famiglia non è un atto scontato, è un processo sul quale si lavora con grande consapevolezza e determinazionee gli equilibri fragili e/o appena formati vengono intaccati. Il fratellino di quasi 4 anni non regge un distacco fisico dal resto della famiglia e siamo costretti ad averlo con noi. Mentre accompagniamo Joshua in sala operatoria e cerchiamo di stemperare l’ansia con sorrisi e filastrocche, va in crisi di panico comincia e urlarmi: “non lo lasciare mamma, portiamolo via! Non lo abbandonare!”. A nulla valgono le nostre rassicurazioni, ma per fortuna Joshua sa il fatto suo e non si scompone minimamente.
Siamo diventati una famiglia proprio tra la corsia e la sala d’attesa, tra la ludoteca e la mensa, fuori della sala operatoria. Sotto lo sguardo del dottore e di tutte le persone che lavorano con dedizione in questo grande ospedale pediatrico.
Quello che ci è mancato in quel primo periodo di percorso sanitario, invece, è stato il supporto di genitori che ci erano passati. Il loro conforto, i loro consigli, poter attingere dalla loro serenità per i momenti di sconforto che la stanchezza fisica ed emotiva portano ad amplificare. Di questa piccola mancanza ora, si fa carico l’associazione BA.BI.S Odv – La banda dei bimbi speciali. Una grande famiglia che raccoglie sia genitori di bambini nati con malformazioni congenite, sia pazienti ormai maggiorenni seguiti dai chirurghi dell’Unità Operativa Complessa Chirurgia Plastica e Maxillofacciale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Perché un genitore rassicurato e preso per mano da chi ha vissuto situazioni simili, riesce meglio a trovare la determinazione necessaria per affrontare la paura e il disorientamento iniziali e ritornare ad essere più coraggioso e più forte di prima.
La serenità del genitore influenza molto la ripresa del piccolo e il suo sereno percorso sanitario. Prendersi cura della famiglia fa parte della presa in cura del piccolo paziente che nel nostro caso cresce felice, vivace e forte. Dal reparto di cardiologia ci dicono che il buco si è quasi chiuso del tutto e noi speriamo lo stesso anche per quell’altro buco, determinato dal suo abbandono.
Ora Joshua ha la sua famiglia. Il suo faro.
(Eleni, 24 giugno 2017)